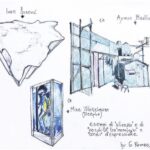di Pino Mantovani
L’abbandono della cittadina, bellissima, dove finalmente aveva trovato ottima dimora con la famiglia, fu traumatico. Perché comportò l’interruzione di consuetudini, di care amicizie e rapporti intellettuali che si ramificavano ben oltre il circuito delle mura. Due fatti avevano sconvolto la vita dell’artista, anzi ne avevano sospeso poi reciso la prosecuzione: la guerra mondiale (prima di un secolo disgraziato) lo aveva sottratto ai suoi esclusivi interessi scaraventandolo in una bolgia senza speranza; una morte violenta in famiglia (per giunta nel momento più confuso e drammatico del massacro generale) lo aveva straziato nella sua carne più segreta e profonda. Questi fatti assurdi, incontrollabili da una intelligenza capziosa ma fragile, sancirono la fine di una stagione felice/infelice secondo una natura sensibile e appassionata, che poteva carezzare l’idea della morte come una sempre reversibile fantasia, coltivare la malattia come una forma poetica di sopravvivenza, esaltarsi o abbattersi senza perdere il filo di un destino segnato, sostanzialmente “bello”. Furono dunque eventi oggettivi, fuori misura fuori senso, a scardinare quel certo modo di esistere del quale aveva fin allora goduto, estraneo per carattere e coltivata aristocrazia al viver comune, ma in esso accovacciato come nel suo giusto nido. Si può dire che la giovinezza prolungata dell’artista sia finita così, urtando in una brutalità che gli negava tutto ciò che per anni lo aveva commosso fino all’esaltazione o alla depressione (al limite dell’eccesso, ma non oltre). La vita ulteriore fu un’altra, che prima nemmeno avrebbe immaginato. Di fatto, si trovò ad affrontare pratiche incombenze, sempre scansate, e a prendere decisioni da capofamiglia; quanto all’arte (già magnifica sofferenza, sofferto divertimento) fu necessario rifondarne il senso, che era venuto a mancare in assoluto e rispetto ad una discontinuità fin qui vissuta come ingegnosa sperimentazione e curiosità di brillanti variazioni, più come inquietudine che ricerca mirata ad un chiaro obbiettivo. A distanza di anni gli piacque affermare, e non si può dire che sia falso, che fu un pittore d’oltralpe a rivelargli che l’arte è rinuncia, che l’arte è un fatto morale, che la forma deve farsi strada attraverso le drammatiche vicende dell’esistenza, anche a costo d’essere impura e imperfetta; mentre aveva sempre pensato che caratteri imprescindibili della forma fossero, almeno in prospettiva, la purezza e la perfezione. La vicenda del nostro pittore fu comunque diversa. La città che lo accolse era più grande complicata dura di quella dolce e coerente che aveva dovuto lasciare, a lui non del tutto ignota per certi parenti e qualche esperienza da giovanissimo; lontana per dislocazione geografica nonché appartata per una sofferta centralità, prima militare e politica poi industriale, la quale aveva sviluppato nei suoi abitanti un naturale atteggiamento di sospetto e resistenza alle novità specialmente dall’esterno, avvertite come pericoloso assedio o indiscreta intromissione. Alquanto a margine anche per cultura ma non provinciale, tanto che all’inizio del secolo – ma non era la prima volta – era stata sede di un evento straordinario tra scienza e arte che aveva avuto peso nella modernizzazione della nazione intera, una di quelle Esposizioni Universali che non di rado determinano svolte epocali. Quando vi si stabilì, forse non aveva altro obiettivo che trovare pace e silenzio, per sé e la sua cara famiglia di donne. Un silenzio che gli avrebbe permesso di riafferrare con maggiore consapevolezza certi fili che aveva dovuto abbandonare a metà dell’opera, anche perché avevano preso a tirarlo in una direzione che sul momento gli riusciva quasi incomprensibile, a meno che non desse credito ad una vena ironica, addirittura sarcastica che non gli era estranea, e di tanto in tanto lo stuzzicava ma anche lo allarmava: sempre più burattini, gli uomini, appesi ad un filo, e pecore/giocattolo condotte da pastori di taglio grezzo. Alla fine di quella strada, intravedeva un mondo ridicolo e pericoloso come tiro al bersaglio per il divertimento dell’idiota di turno. Ma di tutto questo non poteva parlare con nessuno tranne che con se stesso, a meno di recuperare qualche vecchio amico, che ancora sentiva da lontano, al quale comunicava l’impossibilità di inserirsi in un presente che avvertiva radicalmente estraneo. Invece, nella città piuttosto grigia che aveva scelto, forse supponendo che fosse adeguata al suo umore, incontrò un imprevisto interlocutore. Di una specie che non aveva mai conosciuto. Fu un incontro strano (a distanza di anni assumerà l’alone del miracolo), che poteva verificarsi solo in un momento del tutto particolare come quello che stava attraversando (lui, certo, ma con lui una società in affanno dopo una guerra più persa che vinta), che tra disperazione e speranza poteva anche covare straordinarie occasioni: tra un uomo che si avviava ai quaranta e uno sbarbatello di nemmeno vent’anni. Sapiente per intelligenza e controllata passione, ignorante di arti figurative ma curiosissimo di tutto e positivamente proiettato su orizzonti aperti, il “fanciullo”; maturo l’artista, deciso a ricominciare daccapo, da una “ingenuità” che aveva conosciuto solo come esercizio intellettuale e che ora gli appariva unico sbocco possibile. Fu un donarsi senza risparmio, perseguito da entrambi con piena convinzione e reciproco vantaggio: al pittore maturo d’età e d’esperienza serviva specchiarsi in una curiosità vorace, in una intelligenza fresca e libera da pregiudizi, e misurarsi con un moralismo inflessibile e innocente, per ridare sangue ad un corpo anemico, voce ad una disillusione che poteva cedere ad asfittico isolamento; al fanciullo serviva constatare che qualsiasi idea, per tradursi in azione efficace, doveva assumere forma concreta chiara ed asciutta, che ne sintetizzasse il senso e ne facilitasse la diffusione senza banalizzare (dunque, i linguaggi dell’immaginazione creativa erano fondamentali). A tutti e due era necessario verificare il valore delle proprie scelte in una didattica rivolta a spiriti vergini, mirata ad una nuova società politica ed estetica fondata sull’etica. Traccia di questo incontro e delle sue conseguenze troviamo in un testo pubblicato dal pittore in memoria dell’amico, morto giovanissimo.

Un tratto specialmente significativo recita: “… l’amicizia che mi legava a lui era tenace completa perfetta”. Sottolineo che l’affermazione si dà fra parentesi, come un inciso che si pone nel centro del breve emozionato discorso, arginando ogni commozione, che pur vorrebbe farsi strada nelle parole: in nome non della razionalità che esclude pianti e rimpianti, e nemmeno della storia che esigerebbe l’elencazione rigorosa di meriti disillusioni patimenti, invece del definitivo riconoscimento di una dimensione etica che ha legato per sempre gli amici in un rapporto di reciproca fedeltà. La morte di uno consegna al sopravvissuto, che a questo punto diventa testimone, la responsabilità di proseguire la via intrapresa, da discepolo fedele. Se diamo credito all’affermazione che l’amicizia fu “tenace completa”, potremo supporre che l’incastro dei contributi dell’una e dell’altra parte sia stato, appunto, “perfetto”: non nel senso di concluso, finito, ma senza imperfezioni giochi o scarti, a voler utilizzare la metafora del “capolavoro” tecnico; alla lettera, esente da segreti o progetti non condivisi, gelosie invidie o altri sentimenti meno che puri. All’insegna di una complementarità dove gli apporti dell’uno e dell’altro realizzano un incastro paritario, dove il disinteresse del singolo genera un interesse comune. Valgono anche le tracce che del rapporto ha lasciato il fanciullo: alcuni articoli e un saggio sul pittore, pubblicati nell’arco di circa tre anni. Sorprende l’incisività delle interpretazioni e la durezza dei giudizi. Ci si domanda come il giovane, che riconosce la propria iniziale ignoranza sull’arte, abbia potuto raggiungere una consapevolezza così alta in tempi così brevi ed abbia osato prendere posizioni tanto esplicite; ma anche come il pittore, sempre attento a controllare selezionare dominare le interpretazioni che lo riguardino, abbia accettato tanto affermativa severità. Viene il sospetto che nel gioco il pittore abbia parte notevole, nemmeno importa se da protagonista o deuteragonista, comunque impegnato a portare contributo a quel rinnovamento che gli appariva necessario e urgente. La consapevole strategia dell’artista sarebbe quella di affidare la responsabilità di decostruzione e ricostruzione della propria opera ad un testimone scelto, mettendo a sua disposizione tutte le informazioni tecniche e gli elementi di giudizio, in fin dei conti la propria esperienza e le proprie idee sul lavoro compiuto e sulle direzioni che intende prendere nell’immediato futuro. Una delega? piuttosto l’esito di un dialogo, dove ciascuna delle parti, tra scienza e ignoranza ugualmente tese dall’intelligenza, s’impegna a tenere sotto controllo il filo del ragionare; concedendo sì l’artista all’interlocutore d’essere l’interprete ma solo a patto che verifichi, con la sua presenza critica proiettata sul mondo, la plausibilità di elucubrazioni pratiche e teoretiche che l’isolamento dell’autore potrebbe minare alla radice. Perché così soltanto potrà oggettivamente compiersi quel processo di “purificazione ” che il pittore avvertiva necessario per accedere ad uno sviluppo non tarato da resti che avrebbero potuto condizionare il seguito. Serviva pertanto una figura forte, intelligente e tutt’altro che disposta a subire diktat. Anzi, a sua volta impegnata nella ricerca di un personale arricchimento che solo un dialogo stretto e impegnativo, onestamente compromesso, avrebbe consentito. In particolare al “fanciullo forte puro vincitore” (caratteristiche che l’artista avverte, in un certo senso, estranee alla propria natura e che peraltro lo seducono; altri potrebbero esserne respinti: “ lo si ama o lo si odia” avrebbe detto), si presenta subito e nel tempo si chiarisce un problema altrettanto oggettivo e originale quanto quello che si poneva all’amico pittore: la necessità di costruire una “vera critica” che rispondesse alle esigenze interpretative, consapevole ma non dipendente dalla teoria, e fosse capace di indicare vie da intraprendere e modi efficaci di percorrenza, non costretti dall’ideologia. Straordinaria, allora, l’occasione: di poter attingere direttamente alla fonte, l’artista che concepisce ed elabora un processo creativo, e di verificare, in stretto contatto con una intelligenza ed una cultura mirate ad obbiettivi precisi, non senza dubbi e ripensamenti, quali siano i meccanismi mentali ma anche materiali che, in problematica spesso intricata e anche contraddittoria successione, si vengono sviluppando dalla prima intuizione fino alla conclusiva realizzazione. Naturalmente tutto questo comporta una piena corrispondenza, ma non esclude una separata responsabilità dell’interprete rispetto all’artista, una distinzione di metodi ed obbiettivi dell’atto critico rispetto all’atto formativo. In particolare da parte del critico la capacità di elaborare un linguaggio adeguato, che non è filosofico ma sa di filosofia, che non è letterario ma sa di scrittura creativa, che non è scientifico ma ha la stessa precisione, che deve saper utilizzare tutti gli strumenti che la modernità ha messo a punto per cogliere la specificità dell’oggetto preso in esame, che sappia la parola ma anche il silenzio, l’attesa. Insomma l’apporto separato ma complementare di chi faccia e di chi legga è il fulcro dell’incontro tra l’artista e l’interprete, che realizza perfezione nell’apporto separato ma unitariamente mirato.
L’artista sopravvisse per decenni al più giovane amico. Per quasi quarant’anni, quel sodalizio rimase sommerso, come si trattasse di un tesoro nascosto, inaccessibile agli estranei. Riaffiorando solo quando l’artista, vicino alla fine, ripensò per l’ultima volta la sua storia.
Nota dell’autore
Ho lasciato anonimi il maturo artista e il giovane geniale, per consentire alla narrazione di scorrere come un apologo esemplare. Escludo anche note documentarie; corrette, però, le citazioni ed esatti i riferimenti storici. Preciso – per chi ne avverta necessità – che i due protagonisti sono Felice Casorati, da Verona a Torino, e Piero Gobetti, nella Torino dopo la grande guerra; che il pittore di riferimento per la svolta è Cézanne.
immagine in evidenza: Felice Casorati, “Natura morta o Manichini”, 1924